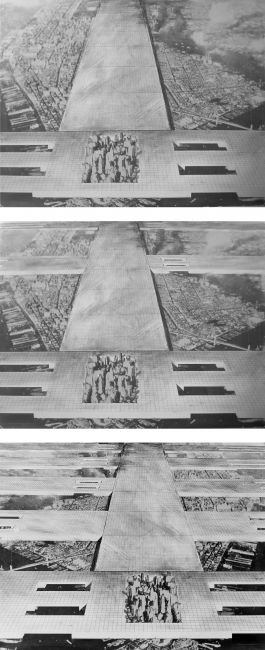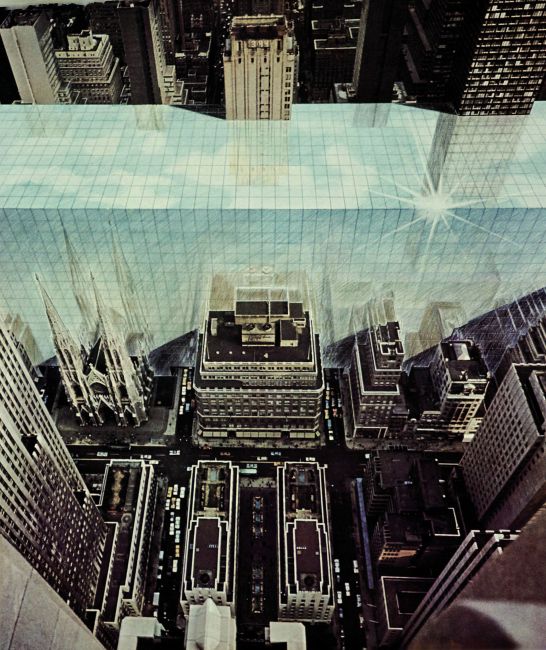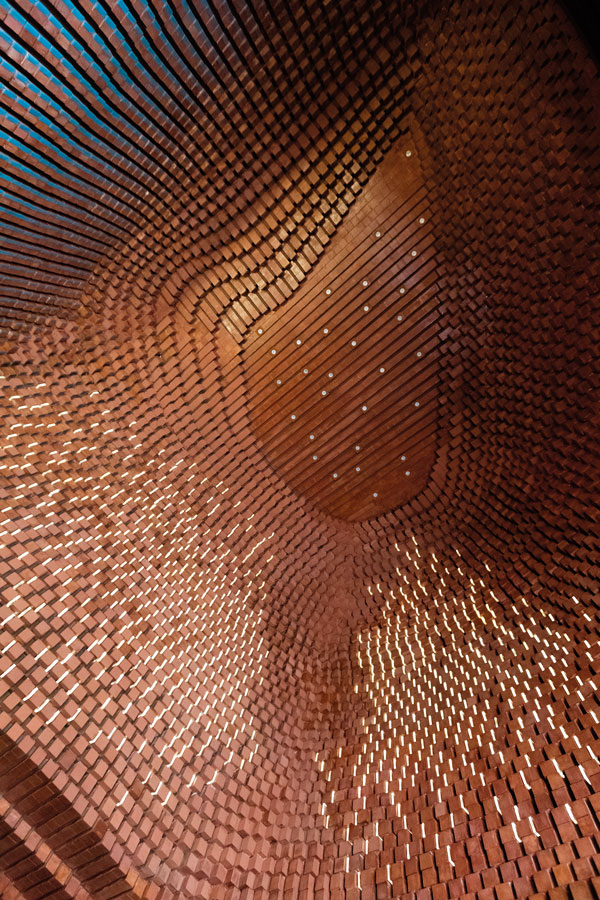Aggiornata al 4.9.2023
Questa informativa è redatta e personalizzata per i visitatori del sito web https://www.laterizio.it/. Il presente documento annulla e sostituisce integralmente il documento che era stato pubblicato in precedenza in tema di cookie.
INFORMATIVA SITO WEB AI SENSI DELL’ART 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)
Specifiche informative di sintesi sono progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta che prevedono form per la raccolta dei dati. La informiamo inoltre che, per fornire un servizio completo, il nostro sito può contenere link ad altri siti web, non gestiti da Edi.Cer. S.p.a.
Edi.Cer. S.p.a non è responsabile di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto illecito, pubblicità, banner o files non conformi alle disposizioni normative vigenti e del rispetto della normativa Privacy da parte di siti non gestiti dal Titolare.
Edi.Cer. S.p.a, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela dei soggetti interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le informazioni ed i dati personali da Lei forniti od altrimenti acquisti nell’ambito dell’utilizzo del sito saranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti
SOGGETTI INTERESSATI E TEMPO DI CONSERVAZIONE
A) utenti (navigatori) del sito web https://www.laterizio.it/.
Tipologia di dati trattati
- Dati di Navigazione: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e di altri dispositivi utilizzati dagli utenti che si connettono al sito; gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste ed eventuali indicazioni temporali delle stesse; parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente; pagine di partenza e di arrivo; indice di Navigazione e comportamenti identificativi durante la visualizzazione delle pagine del sito.
- Dati personali forniti volontariamente dall'utente: l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito e la compilazione di form presenti sul medesimo comporta la successiva acquisizione dei dati personali del mittente (a mero titolo esemplificativo nome, cognome, indirizzo mail). Specifiche informative di sintesi sono presenti nelle pagine che prevedono i form.
Finalità del trattamento: i Suoi dati raccolti durante la navigazione verranno trattati per le seguenti finalità.
- 1) svolgimento di operazioni strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli utenti o dei visitatori del sito;
- 2) raccolta, conservazione ed elaborazione dei suoi dati per analisi statistiche anche in forma anonima e/o aggregata; analisi statistiche volte alla verifica della qualità dei servizi offerti dal sito;
- 3) condividere con i gestori dei social network l’interazione effettuate e dei Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui sono installati i cookie che integrano prodotti o funzioni software
- 4) migliorare l’esperienza di navigazione al fine di inviare servizi e messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione
Il trattamento dei dati per l’espletamento della finalità di cui al punto 1 è necessaria per adempiere ad una sua richiesta e l’eventuale rifiuto potrebbe limitare e/o impedire l’utilizzo in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul sito. La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui al punto 1 è l’adempimento di una sua richiesta, ai sensi dell’articolo 6.1.b.) del GDPR; l’eventuale Suo rifiuto di conferire tali dati implicherebbe l’impossibilità di consultare il Sito.
Il conferimento dei dati indicati nella finalità 2,3 e 4 è facoltativo sulla base giuridica del consenso, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette le funzionalità e i servizi presenti sul sito. La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati per la finalità di cui al punto 2, 3 e 4 è facoltativo, ai sensi dell’articolo 6.1.a). Il consenso viene prestato tramite l’informativa breve cliccando sulla parola “ACCETTA” presente nell’informativa breve. Relativamente al conferimento facoltativo vengono rese maggiori informazioni relative ai cookie presenti sul sito nel documento cookie policy accessibile anche dall’informativa breve.
I dati di navigazione sono conservati per i tempi indicati nella cookie policy disponibile sul sito.
COOKIE ED ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO
I suoi dati sono raccolti anche mediante strumenti e servizi erogati da terze parti e conservati dagli stessi. Per maggiori informazioni si rimanda al documento “cookie policy”
Si avvisa che Edi.Cer. S.p.a funge meramente da intermediario per i link riportati nella cookie policy e non può assumersi nessuna responsabilità in caso di eventuale modifica.
B) utenti sezione registrati
Compilando i form accessibili nella sezione “Registrati” i Suoi dati saranno utilizzati per permetterle l’accesso all’area riservata che le permetterà l’accesso ai servizi previsti all’interno dell’area a lei dedicata (analisi statistiche che permettono di identificare i visitatori, analisi statistiche volte alla verifica della qualità dei servizi offerti dal sito , ecc.). Il conferimento dei dati per tali finalità è l’adempimento di una Sua richiesta. La base giuridica del trattamento è l’art. 6.1.b) del GDPR. I suoi dati, previo suo consenso prestato mediante selezione dell’apposita casella marketing, saranno utilizzati per l’invio di informazioni commerciali e pubblicitarie aventi oggetto messaggi informativi e comunicazioni commerciali, promozionali relative all’attività e ai prodotti di Il conferimento dei Suoi dati per tale finalità è facoltativo e non compromette la sua registrazione. La base giuridica del trattamento è l’art. 6.1.a.) del GDPR. In ogni momento potrà opporsi al trattamento utilizzando il link presente in calce alla mail oppure tramite l’invio di una richiesta al Titolare ai recapiti indicati nella presente informativa.
I suoi dati saranno conservati per i tempi necessari per l’erogazione del servizio da Lei richiesto e per la finalità di marketing fino a quando Lei non deciderà di cancellare la sua iscrizione al servizio oppure opporsi al trattamento.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali saranno trattati con modalità manuali, elettroniche e/o telematiche, mediante l’utilizzo di cookie (come indicato nella cookie policy disponibile sul sito) a mezzo di calcolatori elettronici con utilizzo di software di terze parti e modalità automatizzate di contatto (e.g. campagne automatizzate di invio di e-mail, SMS, contatto telefonico automatizzato, messaggistica istantanea, social network, ecc., nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Il Titolare per confrontare ed eventualmente migliorare i risultati delle comunicazioni, utilizza sistemi per invio di newsletter e comunicazioni promozionali con report
UTILIZZO PIATTAFORME SOCIAL
Edi.Cer. S.p.a può anche fornire collegamenti (link) ad altre piattaforme di social media che conducono a server installati da individui o organizzazioni su cui non ha alcun controllo. Edi.Cer. S.p.a non fornisce alcuna rappresentazione, né assume alcuna responsabilità riguardo l’accuratezza o qualunque altro aspetto delle informazioni disponibili presso tali siti. Il collegamento (link) ad un sito di un terzo non può essere inteso come una validazione, né da parte di Edi.Cer. S.p.a, né di tale terzo, dei prodotti e servizi di altri o tale terzo. Edi.Cer. S.p.a non rilascia dichiarazioni o garanzie riguardo l’uso o l’archiviazione dei dati dell’utente presso i siti di terzi. Si invitano i signori utenti ad esaminare attentamente la policy sulla privacy che regola i siti di terzi collegati al nostro sito web per avere una visione completa del possibile utilizzo dei Vostri dati personali
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE DEI DATI
I suoi dati saranno trattati da personale opportunamente incaricato e saranno comunicati all’esterno a società che agiscono in qualità di autonomo Titolare o Responsabile del trattamento:
- soggetti esterni che forniscono servizi in cloud;
- fornitori di servizi di assistenza tecnica;
- società del gruppo che forniscono i servizi per la gestione del sistema informatico, ivi inclusi i servizi di hosting dei server e di backup;
- nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto.
L’elenco completo può essere richiesto scrivendo ai recapiti del Titolare
I suoi dati non saranno oggetto di diffusione.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati possono essere trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione Europea come indicato nella Cookie Policy delle società che erogano i servizi relativi ai cookie di terze parti. Per maggiori informazioni scrivere a info@edicer.it.
Per esigenze tecniche e/o organizzative i suoi dati sono trasferiti verso paesi appartenenti all’Unione Europea.
Per l'invio delle comunicazioni aziendali i suoi dati possono essere trasferiti verso paesi appartenenti all’Unione Europea: tale trasferimento è in ogni caso legittimo in quanto garantito dalla sussistenza di decisioni di adeguatezza emesse dalla Commissione Europea e/o di clausole tipo di protezione sulla base dei modelli adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46 del GDPR.
Lei potrà richiedere al Titolare la copia delle misure di salvaguardia adottate per il trasferimento extra UE dei Suoi dati personali, nonché l’informazione sui luoghi ove le stesse sono state rese disponibili, formulando una specifica richiesta al Titolare tramite l’indirizzo e-mail a info@edicer.it.
MINORI
Il Sito non è diretto all’utilizzo da parte di minori e non sono raccolti dati di minori da parte del Titolare. Nel caso in cui il Titolare sia a conoscenza della raccolta di tali dati (es. tramite il form di contatto) li cancellerà immediatamente. Il Titolare risponderà alle richieste di informazioni in conformità con le leggi applicabili. Si ricorda che l’esercente la responsabilità genitoriale è tenuto nel caso di richieste di informazioni a fornirci il consenso alla raccolta dei dati personali del minore.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Edi.Cer. S.p.a, con sede legale in Via Monte Santo 40 – 41049 Sassuolo, info@edicer.it nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 scrivendo a info@edicer.it. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
APPLICAZIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA
Se avete dubbi riguardo la presente Informativa, contattate innanzitutto Edi.Cer. S.p.a inviando una e-mail all’indirizzo info@edicer.it oppure contattando il Titolare ai recapiti aziendali forniti nel presente documento.
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
Edi.Cer. S.p.a si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa per adeguarla al diritto sopravveniente, nonché tenendo in debita considerazione i suggerimenti trasmessi da dipendenti, clienti, collaboratori e utenti. In caso di modifiche da parte di Edi.Cer. S.p.a, verrà tempestivamente aggiornata l’Informativa Privacy presente sulla pagina principale di privacy e sulla Homepage del sito web https://www.laterizio.it/
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o personale autorizzato al trattamento dei dati personali.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale